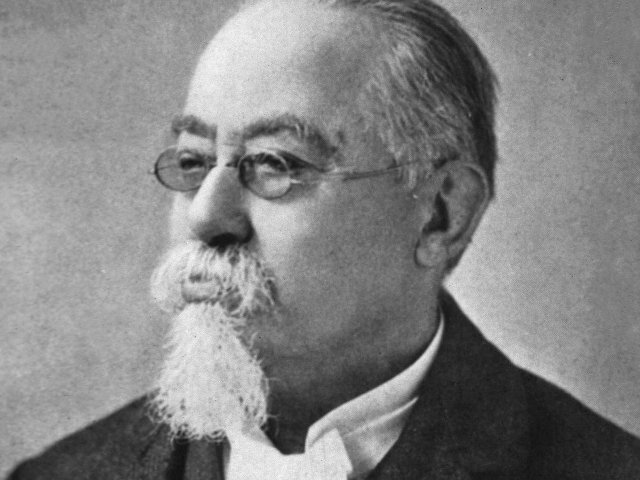
Un crimine non ha lo stesso identico valore per tutti gli uomini. Entrano infatti in gioco molteplici parametri che hanno il ruolo di variarne l’interpretazione, rendendolo così un evento la cui gravità è vincolata alla società, al luogo, al periodo storico e all'ambiente. Di conseguenza, anche la perseguibilità di quel crimine cambia. Secondo il diritto penale, esso è regolato da un “teorema” incontestabile “nullum crimen sine lege” (non vi sono delitti se non quelli puniti dalla legge). Sta di fatto però, che qualunque sia stato l’atteggiamento repressivo nei confronti del delitto presente in una società, l’uomo è sempre stato profondamente colpito dal fenomeno criminale. Da quando abbiamo memoria scritta della cultura umana, sappiamo che in tutte le categorie sociali è stato oggetto di discussioni e soprattutto si è cercato di stabilire le motivazioni che inducono gli uomini a commettere reati. Gli strumenti per effettuare studi sul crimine erano naturalmente in linea con i tempi e le civiltà in cui erano applicati. La maggior parte risultano oggi, ovviamente superati, e totalmente svincolati da ogni possibile legame con il pensiero scientifico.
Vi fu un periodo, in cui, nel mondo occidentale cristiano, alcuni crimini erano correlati all'influenza diabolica: si credeva infatti che all'origine di numerosi delitti vi fossero oscure presenze infernali, agenti in modo distruttivo nella quotidianità attraverso figure emblematiche come le streghe. Soprattutto in casi del genere il crimine diventava così un ambito in cui giocava un ruolo importante il soprannaturale, cioè un contesto difficilmente definibile attraverso parametri giuridici. Per cercare di definire con gli strumenti adatti il fenomeno, venne infatti creato il Tribunale dell’Inquisizione: un tribunale ecclesiastico che con procedure estranee al diritto romano si occupò dei crimini in cui entravano in causa il diavolo, le streghe ed altre figure della mitologia.
La più antica indicazione dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti del crimine da cui sia possibile evincere un’impostazione razionale, allineata ai modelli che potremmo definire legislativi, è costituita dal Codice di Hammurabi, il cui nome deriva dal re babilonese che regnò in quell'area della Mesopotamia dal 1792 al 1749 a.c.. Esso, contiene 282 sentenze del re scolpite su una stele di pietra che misura poco più di due metri. Sotto il profilo giuridico, il Codice di Hammurabi è il primo elenco organico di leggi a noi pervenuto, con il ruolo di essere consultabile pubblicamente, esplicitando il moderno concetto giuridico della conoscibilità della legge. In questa raccolta occupa una posizione di rilievo la cosiddetta “Legge del taglione”, che si affermò anche in seno alla tradizione giuridica giudaica secondo il ben noto detto “occhio per occhio, dente per dente”. Una particolarità invece, il fatto che non vi sia distinzione tra volontario e colposo: l’autore era infatti riconosciuto comunque colpevole del danno provocato.
Sulla scia del Codice di Hammurabi vanno poste le leggi ittite; i documenti più antichi a noi noti sono alla fine del XIII secolo a.c. e rivelano una notevole modernità: infatti contemplano la distinzione tra omicidio volontario e colposo; vi sono inoltre norme riguardanti la violenza, le lesioni personali e l’aborto. Articolata e strutturata è invece l’opera di controllo della criminalità nel mondo greco-romano, anche se la ricerca dell’attività criminale era affidata soprattutto al pensiero filosofico, piuttosto che a quello scientifico. Non mancano comunque importanti valutazioni legislative che ponevano in evidenza, ad esempio ad Atene, la distinzione tra danno involontario e danno intenzionale: ognuno dei quali veniva diversamente sanzionato. Lo studio del crimine, a partire da Medioevo, si avvalse non solo della giurisprudenza, ma ebbe un contributo rilevante da quell'ambito della medicina che oggi accompagnamo con l’aggettivo legale. Naturalmente allora l’analisi era condotta con i metodi del tempo. Ma abbiamo comunque fonti che possono essere considerate delle vere e proprie indagini necroscopiche finalizzate a stabilire le cause di morti apparentemente naturali, ma in realtà di origine violenta.
Tra il XVI e il XVII secolo, la medicina legale con le sue implicazioni criminologiche, acquisì maggiore autorevolezza e autonomia, conquistando un ruolo giuridico e sociale fondamentale. Alcune scienza che fino ad allora avevano svolto ruoli paralleli, ad esempio la psichiatria, o in alcuni casi ai margini della società come la fisiognomica, ebbero modo di far convergere i loro strumenti in direzione della scienza del crimine. Scienza che acquisterà ufficialmente la propria dignità nel 1876 , con la pubblicazione della prima edizione de “L’uomo delinquente” di Cesare Lombroso.
Giulia Meozzi
Tutte le notizie di GoBlog



