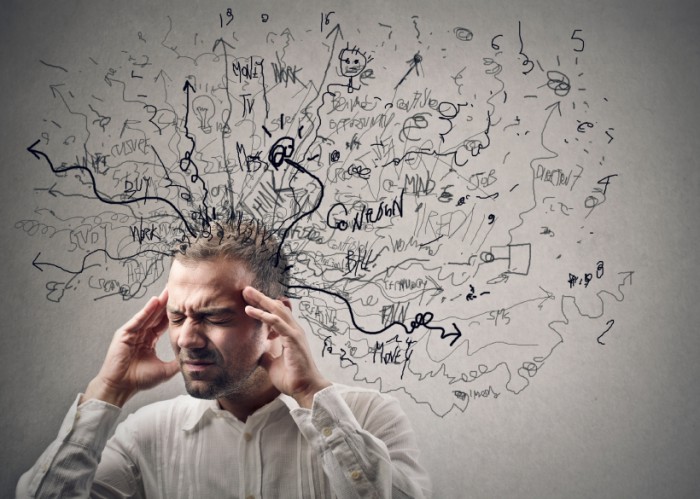
Ad ognuno di noi, nell’arco della propria vita, sarà sicuramente capitato di sentirsi preoccupato per un evento o una situazione; in questo caso le preoccupazioni possono avere un ruolo costruttivo, produttivo e positivo, in quanto dispongono l’individuo a reagire, risolvere i problemi e diminuire l’ansia. Quando la preoccupazione diventa eccessiva e sfugge al controllo di una persona, quest’ultima passa la maggior parte del suo tempo a pensare ed a rimuginare continuamente a ciò che è fonte di preoccupazione; tanto da sentirsi schiacciato ed intrappolato da questi pensieri, facendo diventare il rimuginio patologico.
I ricercatori e psicoterapeuti Sassaroli e Ruggiero, definiscono il “rimuginio” come un fenomeno clinico, caratterizzato da ripetitività e capacità pervasiva di occupare spazio mentale. secondo gli studi effettuati da Borkovec, le caratteristiche fondamentali del rimuginio sono la predominanza del pensiero verbale negativo, a svantaggio di quello immaginativo, l’evitamento cognitivo e l’inibizione dell’elaborazione emotiva.Il rimuginio non sarebbe un comportamento disfunzionale poiché, come già detto, consente di prendere una decisione pratica, tuttavia può diventare disadattivo in quanto una condizione ripetuta nel tempo di inibizione emotiva può portare ad una stabilità di emozioni sgradevoli. Inoltre, il rimuginio cronico ha grosse influenze sulla salute fisica e mentale, poiché motivo di problemi cardiovascolari, tensione muscolare, insonnia, problemi interpersonali. Sassaroli e Ruggiero ritengono che il rimuginio patologico (tipico dei disturbi d’ansia in generale e del disturbo d’ansia generalizzato in particolare) sarebbe caratterizzato dalla ripetizione continua degli elementi che caratterizzano il problema, il quale viene predetto come catastrofico e a cui non segue una decisione operativa, in quanto tutte le ipotesi prese in considerazione dal soggetto, risultano non adeguate e non risolutive, quando ci ritroviamo di fronte ad una minaccia, incerta ed indefinita, che pare portare ad un attacco decisivo, irreversibile, irrimediabile e catastrofico. Il rimuginio, perciò, è una ripetizione mentale continua del timore del danno incontrastabile senza la rappresentazione di scenari concreti di attuazione. Il rimuginio quindi risulta essere inefficace ed improduttivo, allora come mai è un fenomeno così presente e pervasivo? Borkovec ritiene che le persone che mettono in atto il rimuginio attribuiscono a questa modalità di pensiero vantaggi e scopi sia favorevoli che produttivi, che vanno a rinforzare il rimuginio stesso.
Allora, quali sono gli scopi positivi del rimuginio? - Ridurre l’ansia, ma questa modalità di pensiero non fa altro che mantenere l’ansia;
- Risolvere le situazioni, in realtà non è così perché la persona rimane ferma e rigida, non elabora alternative concrete ed efficaci. Non vengono prese in considerazione strategie alternative per far fronte alla minaccia, perciò quest’ultima rimane e così anche il rimuginio;
- “Scudo emozionale”, cioè, la persona pensa che il rimuginio lo mantenga in uno stato di allarme e che lo tenga quindi pronto ad affrontare la situazione temuta;
- Attività distraente da preoccupazioni peggiori, studi effettuati hanno messo in luce che le persone che tendono a rimuginare hanno una probabilità di prevedere eventi negativi e catastrofici molto maggiore dei soggetti che non tendono a rimuginare;
- Rimuginio ascopico, i soggetti non sono in grado di spiegare i motivi per cui rimuginano, quindi il rimuginio sembra non avere uno scopo ben preciso. Per questo viene visto come qualcosa di incontrollabile al quale è difficile sottrarsi.
Quali sono i fattori che mantengono il rimuginio? I fattori che mantengono il rimuginio, malgrado non porti ad effetti, sono: la credenza positiva legata al rimuginare, credenza che da questa modalità di pensiero dipende il fatto che la situazione temuta non si sia realizzata ed inibizione del manifestarsi di emozioni ed attivazione fisiologica negative.
Cosa fare per non rimuginare? Potrebbe essere opportuno seguire queste istruzioni:
- Riuscire a riconoscere i pensieri negativi che contraddistinguono il rimuginio, differenziandoli da quelli più adatti rivolti al momento presente.
- Scegliere un momento, di circa mezz’ora, all’interno della giornata (possibilmente sempre alla stessa ora e trovandosi nello stesso posto) da dedicare al rimuginio.
- Interrompere e posticipare il rimuginio al momento opportuno, quando ci accorgiamo di rimuginare nel momento non decretato.
-Durante la mezz’ora dedicata al rimuginio impegnarsi per identificare soluzioni che permettano di affrontare ed eliminare le preoccupazioni.
Immaginare conseguenze negative non aiuta sicuramente a prevenirle, rappresentarsi la scena peggiore di un evento, non aiuta a evitarla. Occorre essere predisposti a correre qualche rischio, dobbiamo imparare a rischiare, non è scritto da nessuna parte che l’esame universitario andrà male o che la mia esposizione in pubblico sarà sicuramente un disastro.È necessario ricordarsi di pensare al concreto e di scegliere quando pensare ai nostri problemi.È una cosa che possiamo imparare a fare!
Ma se l’ansia e lo stress determinate dal rimuginio si mantengono, probabilmente è il caso di una consulenza psicologica.
Nel caso in cui vogliate suggerirci un argomento da affrontare o esporci una vostra problematica o preoccupazione scriveteci a studiopsicologicoilcammino@gmail.com e noi vi risponderemo o pubblicando la lettera in forma anonima o affrontando la tematica da voi richiesta.
Federica Giacinti




