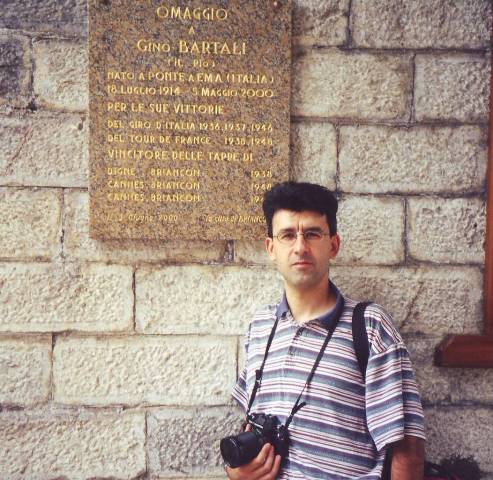Il 18 novembre scorso, con una cerimonia alla sinagoga di via Farini, a Firenze, è stato consegnato alla memoria di GinoBartali l’attestato di “Giusto fra le nazioni”, il riconoscimento con cui lo Stato di Israele onora i non-ebrei che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare anche un solo ebreo dallo sterminio nazista.
Il nome del popolare “Ginettaccio”, scomparso nel 2000 all’età di 86 anni, è stato così inserito nello Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto, per l’aiuto prestato durante l’occupazione tedesca della penisola, quando Bartali transitava in bicicletta sulla Terontola-Cortona-Assisi per recapitare i documenti falsi che consentirono a centinaia di ebrei di sfuggire al fatale destino della deportazione: «Son Bartali, mi vò ad allenare», diceva disinvoltamente ai militari che presidiavano i posti di blocco e che lo facevano passare non sospettando il vero scopo delle sue pedalate.
Dopo che la carriera e la vita di Bartali sono state riproposte e studiate in libri e sceneggiati e i suoi tratti fisico-caratteriali eternizzati nella celeberrima canzone di Paolo Conte (Quel naso triste come una salita/Quegli occhi allegri da italiano in gita), è impossibile arricchire la descrizione della personalità del corridore toscano, se non precisando che su quelle arrischiate missioni del tempo di guerra Bartali mantenne in vita un pudico riserbo. Tanto fu esuberante, estroverso e polemico come ciclista, tanto preferì che il suo lascito più grande come uomo rimanesse lontano dallo sguardo del pubblico.
Ne è derivato un originale paradosso: se l’onorificenza conferitagli da Israele getta ora un’inequivoca luce chiarificatrice su episodi cruciali ma sottaciuti e non pubblicizzati della sua vita, restano invece circondate da un alone di leggenda e quindi di mistero altre vicende di cui si parla e si discute animatamente da più di sessant’anni. Mi riferisco ovviamente ai riflessi politico-sociali della clamorosa vittoria al Tour de France del 1948 e alla gustosissima querelle che divide irrimediabilmente bartaliani e coppiani sul passaggio della borraccia nell’iconica immagine scattata sul Col du Galibier nel 1952. Ed ecco i fatti.
Al Tour del 1948, Bartali vinse la prima tappa e indossò la maglia gialla, ma subito cedette il simbolo del primato al più giovane idolo di casa Louison Bobet, precipitando a oltre 21 minuti di distacco. Il 14 luglio, festa nazionale in Francia, i corridori osservarono un giorno di riposo e a Roma, il segretario del Pci, Palmiro Togliatti, fu raggiunto da alcuni colpi di pistola sparatigli all’uscita di Montecitorio dal neofascista Antonio Pallante. Come l’Europa era tagliata in due dalla “cortina di ferro”, così L’Italia era allora aspramente divisa fra democristiani da una parte e social-comunisti dall’altra, come avevano sancito le elezioni generali del precedente 18 aprile, tenutesi dopo la fine dell’unità nazionale seguita al conflitto mondiale e la conseguente esclusione dei ministri comunisti e socialisti dal Governo. Quella tornata elettorale era stata segnata da recise contrapposizioni e il successo della Dc, che raggiunse la maggioranza assoluta dei seggi, decise in via definitiva l’appartenenza del nostro Paese alla sfera d’influenza degli Stati Uniti, archiviando le speranze di rivoluzione che pure albergavano in ampi strati della popolazione.
Con Togliatti agonizzante in un letto di ospedale, il latente clima di divisione esplose in tutta la sua virulenza. La CGIL proclamò lo sciopero generale e spontaneamente si diffusero occupazioni di fabbriche e di centri telefonici, blocchi stradali e interruzioni del traffico ferroviario: sedici morti e numerosi feriti funestarono gli scontri fra polizia e manifestanti, spingendo l’Italia sull’orlo di una sanguinosa guerra civile. In questa situazione incendiaria, il Tour riprese il suo cammino e nella tappa del 15 luglio Bartali vinse infliggendo 20 minuti a Bobet. Lo stesso accadde nelle due frazioni successive di Aix-Le-Bains e Losanna. La maglia gialla tornò all’italiano, che trionfò a Parigi con quasi mezz’ora di vantaggio sul secondo arrivato – bissando il successo del 1938, Bartali divenne l’unico corridore della storia a vincere due edizioni della Grande Boucle a dieci anni di distanza.
Il capolavoro di Bartali si completò mentre in Italia si attenuavano gli impeti di rivolta e Togliatti veniva dichiarato fuori pericolo. La stampa moderata volle però accreditare l’idea che l’allentamento della tensione fosse da attribuire all’insperato risultato del Tour, ottenuto anche sulla spinta di una telefonata di incoraggiamento fatta dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi al pio ciclista fiorentino alla vigilia della favolosa tre-giorni alpina, telefonata sui cui contenuti i testi storici riportano versioni discordanti. In realtà, se è vero che l’impresa di Bartali contribuì a svelenire il clima deviando l’attenzione delle masse popolari sulla corsa francese, la tesi dello stretto rapporto di causa ed effetto non regge a un esame rigoroso degli eventi di quei giorni caotici: l’ipotesi della sollevazione generale era stata scartata dallo stesso Togliatti, che entrando in sala operatoria aveva raccomandato calma e prudenza ai dirigenti comunisti; nella notte fra il 15 e il 16 luglio, Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGIL, aveva revocato lo sciopero generale che paralizzava il Paese e la piena rimonta di Bartali, dopo un giorno di riposo, poté dirsi compiuta solo il 18 luglio, quando il rischio della “tragica insurrezione dei rossi contro la libertà” era svanito completamente. Tuttavia, l’emozionante intreccio di quell’infuocato luglio è indubbiamente il segno della dilagante popolarità del ciclismo e della valenza anche e soprattutto metaforica che all’epoca veniva attribuita alle gare in bicicletta, che insieme al calcio e al cinema neo-realista costituivano uno dei pilastri su cui poteva riedificarsi il senso di identità e di appartenenza degli italiani, umiliati agli occhi del mondo da vent’anni di dittatura, dall’esito della guerra e dalle immani ferite umane e materiali che questa aveva lasciato in eredità.
I riflessi extra-sportivi dell’epopea del ciclismo nell’immediato dopo-guerra emergono anche nella rivalità che oppose Bartali a Fausto Coppi e che spaccò in due le falangi di tifosi e appassionati. L’avvincente dualismo fu interessatamente cavalcato dagli organi di stampa, che lo sfruttavano per incrementare il seguito delle corse e le vendite dei giornali che le raccontavano. Anche i molti intellettuali che commentavano i grandi Giri calcarono oltre misura le differenze fra i due rivali. Indro Montanelli, Dino Buzzati e Curzio Malaparte, fra i tanti, accreditarono l’idea di un contrasto di personalità e di caratteri che travalicava il mero antagonismo agonistico: Bartali il pio e Coppi il laico, Bartali di destra e Coppi di sinistra (in realtà, entrambi firmarono l’appello dei ciclisti a votare Dc alle elezioni del 1948), il primo devoto alla Madonna e il secondo in odore di eresia per la relazione extra-coniugale con Ilaria Occhini, l’uno irascibile e impetuoso, l’altro schivo e ritirato.
I due erano fieri avversari in bicicletta, si riferivano l’uno all’altro come a “quello là” – così alimentando e deridendo al tempo stesso la contrapposizione amplificata dai mass media – e non mancarono di dare dimostrazione di mutua ostilità sportiva, come ai Mondiali di Valkenburg del 1948, quando a furia di “marcarsi” reciprocamente lasciarono la maglia iridata al belga Alberic Schotte, meritandosi la squalifica di un mese decretata dalla Federazione ciclistica per la condotta di gara disonorevole.
La rivalità artatamente enfatizzata era funzionale anche alla complementare esaltazione dei momenti di vicendevole solidarietà, quando gli stessi cronisti che esacerbavano il contrasto fra i due magnificavano la concordia ritrovata in nome del supremo interesse nazionale. Come accadde al Tour del 1952, nella terribile tappa del 6 luglio: quel giorno la carovana deve affrontare il Glandon (1.951 metri), la Croix de Fer (2.067), il Telegraph (1.600), il Galibier (2.556) e il Monginevro (1.854), prima dell’arrivo in terra italiana, al Sestriere (2.033).
Coppi indossa la maglia gialla (non la lascerà più fino a Parigi), avendola conquistata nella frazione precedente, che per la prima volta aveva portato i corridori ai 1.860 metri dell’Alpe d’Huez. Sull’ascesa del Galibier, con il sole che picchia, avviene il fatto incredibile: Gino e Fausto si passano la borraccia, l’immagine viene immortalata dal fotografo Carlo Martini e poi pubblicata su “Lo sport Illustrato” il successivo 10 luglio.
Tanto basta a scatenare il processo di trasfigurazione in mito di una vicenda sportiva. I tifosi si domandano invano chi abbia passato a chi la borraccia (in effetti, una bottiglia) e cominciano a polemizzare fra di loro, avviando l’incessante elaborazione di un’immagine che presto diviene il simbolo di un’intera stagione del ciclismo italiano e internazionale, la prova inconfutabile che la cavalleria e il fair-play possono convivere con la competizione estrema. Con inaspettato senso del teatro, gli stessi Bartali e Coppi alimentano l’inesauribile diatriba, cambiando le versioni di volta in volta fornite o dando risposte evasive. Lo stesso fa Carlo Martini, che aveva progettato lo scatto, chiedendo a un amico di passare la bottiglia ai due campioni, affinché se la scambiassero davanti al suo obiettivo. Né serve a qualcosa congetturare sull’indole dei protagonisti e sulle diverse prestazioni di quel giorno (Coppi andò a vincere al Sestriere, distaccando Bernardo Ruiz di 7 minuti e il 38enne Bartali di oltre 10), o riandare ad analoghi episodi del passato quale quello avvenuto sui Pirenei nel 1949 quando era stato Fausto a dissetare Gino rimasto a secco, o anche visionare un filmato (oggi facilmente reperibile in rete) di quello stesso 6 luglio, dove si vede distintamente “Ginettaccio” cedere la propria borraccia all’amico-rivale, che beve e improvvisa una doccia rigenerante.
Il mistero resta insondabile e si erge a rappresentazione plastica di una storia leggendaria da tramandare a chi non l’ha vissuta, a simbolo di una rivalità sportiva mai più ripropostasi con tanta varietà di significati e di cui gli stessi protagonisti andavano orgogliosi, come fu evidente nel 1959 alla famosa trasmissione del “Musichiere” di Mario Riva, quando i due campioni – duettando sull’aria di “Come pioveva” - rivelarono l’unica verità possibile: Fummo rivali, però cordialmente/Fummo nemici, ma sempre lealmente/L’antagonismo che ci divideva/Come piaceva, come piaceva!
Paolo Bruschi